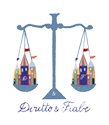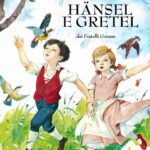Perché il patto di famiglia (artt. 768 e ss. c.c.) costituisce una deroga al divieto patto successorio (art. 458 c.c.)?
Per poter spiegare la ragione per cui il patto di cui all'articolo. 768 bis c.c. deroga al divieto di cui all'art. 458 c.c. è necessario procedere per ordine.
Le due sorelle Elsa ed Anna della fiaba Frozen sono eredi legittimarie o c.d. necessarie del Re e della Regina di Arendelle.
Chi sono gli eredi legittimari e quali diritti possono azionare?
Gli eredi legittimari, ai sensi dell'art. 536 c.c., sono: il coniuge, i figli ed, in mancanza di questi ultimi, gli ascendenti.
Agli eredi legittimari o c.d. necessari la legge riserva una quota di eredità. Tale quota c.d. di riserva è intangibile. Ciò implica che colui che redige testamento non può disporne, escludendola o riducendola.
Se il testatore viola tale divieto gli eredi necessari totalmente o parzialmente pretermessi possono agire per vedere reintegrata la quota di riserva loro spettante mediante l'azione di riduzione disciplinata agli artt. 554 e ss. c.c..
Come spiegato nel precedente articolo, intervenendo nel patto di famiglia i partecipanti (eredi legittimari) non assegnatari possono:
- essere liquidati dai discendenti assegnatari dell'impresa: c.d. credito alla liquidazione (in via esemplificativa i discendenti assegnatari possono scorporare dall'azienda un cespite e soddisfare con questo i diritti dei legittimari;
- rinunciare al diritto alla liquidazione.
Ritorniamo sulla nostra fiaba. Il Re e della Regina di Arendelle quindi stipulano con Elsa ed Anna un patto di famiglia con il quale trasferiscono il diritto di proprietà del Regno di Arendelle alla figlia Elsa.
Nel medesimo patto Anna, erede legittimaria certa che la sorella gestirà al meglio il Regno, rinuncia al diritto di credito alla liquidazione in quanto impegnata nell'attività di vendita di ghiaccio con Kristoff.
Il patto di famiglia non costituisce una deroga al divieto di patti successori per la parte del patto relativa al trasferimento dell'azienda da parte dell'imprenditore ai discendenti.
Tale parte del patto, infatti, non può essere ricompreso nel patto successorio istitutivo vietato ai sensi dell'art. 458 c.c. in quanto ha un effetto traslativo immediato e definitivo, non riconducibile alla successione del futuro dante causa.
Il contratto ex art. 768 bis c.c. è, infatti, un contratto tra vivi con il quale il disponente non regola la propria successione né a titolo universale né a titolo particolare, bensì la anticipa tramite l'assegnazione del bene produttivo o delle partecipazioni sociali.
Diverso è il ragionamento relativamente all'esercizio del diritto alla liquidazione o di rinuncia alla liquidazione operata dagli eredi legittimari partecipanti non assegnatari.
I patti di famiglia costituiscono un'eccezione al divieto di patti successori dispositivi e rinunziativi per la parte dell'accordo in cui è prevista la liquidazione del legittimario non assegnatario, il quale dispone dei propri diritti successori spettanti sui beni oggetto del patto.
Il patto in esame costituisce, altresì, una deroga al divieto di patti successori rinunciativi in quanto comporta la rinuncia all'azione di riduzione ed alla domanda di collazione ai sensi dell'art. 768 quater, comma 4, c.c. e quindi una rinuncia a diritti che spetterebbero agli eredi legittimari solo nel momento dell'apertura della successione.
In conclusione Anna, rinunciando ad agire in riduzione relativamente al diritto di proprietà sul Regno di Arendelle, dispone di diritti che le sarebbero pervenuti mortis causa in forza della successione, quale erede legittimaria, dei genitori regnanti.